
Il viaggio è donna. Una mappa identitaria e, al contempo, una geografia dei corpi. E’ quanto ci consegna il bel saggio di Lucie Azema, Donne in viaggio. Storie di itinerari di emancipazione (Edizioni Tlon, 18 €, trad.it Nunzia De Palma).
I corpi di cui parla Azema – classe 1989, viaggiatrice e femminista francese – sono tutti femminili. Seguiamo idealmente le tracce di Penelope invece che la mitopoietica di Ulisse. Le storie sono gomitoli da disfare. Gli eroi e il viaggio virtù di un patriarcato che ha sedotto e abbandonato, come Teseo che, dopo aver sconfitto il minotauro grazie al filo di Arianna, la pianta in Nasso (altro che “in asso”, la sbarca su un’isola, dove però troverà Dioniso ad attenderla).
Il territorio di ricerca di Azema è la cartografia del suo continente interiore. Un mondo popolato da variopinti uccelli, avventure che gli uomini, con la loro sete di conquista, il mito della virilità, possono solo immaginare.
Nel testo scorrono le immagini della viaggiautrice: Libano, Egitto, Beirut, Jaipur. L’estensione del continente interiore di Azema si fa criterio di scelta con gli anni. Le parole con le quali si nutre sono il lessico del mondo. Parole che sono sempre una nuova partenza. Un’impresente lotta alla mitizzazione dell’avventura del maschio. Avventura che nel caso di personaggi uomini sarebbe lecita, mentre invece a dare dell’avventuriera a una donna si penserebbe subito, denuncia la femminista, a una “poco di buono”. Una che ‘se le va a cercare’. Come Pippa Bacca, l’artista italiana morta durante il suo viaggio-performance itinerante Spose in viaggio, in 11 tappe: stuprata e uccisa a Gebze dall’uomo che le diede un passaggio in autostop.
Identificazione nelle eroine (anche ‘eroina’ a guardar bene potrebbe assumere una connotazione negativa), capacità, sostanza. Sono tutte cose che Azema denuncia, quando si pensa alle donne non si dicono: l’avventuriera una figura d’eccezione, inadatte all’esplorazione, le donne possano al più divenire angeli del focolare domestico, retrocesse a paredre del dio-uomo. Così scopriamo i nomi delle eccezioni, le “persone eccezionali” essendo sempre gli uomini nella Storia: come Jeanne Barret, botanica, che si dovette fingere uomo, marinaio, per far parte dell’equipaggio che fece il primo giro del mondo.
Sono gli itinerari della civiltà basata sulla performance della maschilità quelli che l’autrice testimonia, il sistema viriarcale più che solo patriarcale. L’indipendenza del proprio corpo, oltre che del proprio pensiero, è un luogo inaccesso alle donne, dalle spedizioni sul Mar Glaciale Artico al “vagabondo” Kerouac, l’impero della maschilità è avanzato, colonizzando il tempo e lo spazio del viaggio.
Il libro di Azema, delle ottime – al femminile – edizioni Tlon, è anche però, e soprattutto, un viaggio nell’altro. Questo termine aconcettuale, così poco indagato. Non a caso apolide nella narrazione del mondo. Così le Storie di itinerari di emancipazione parlano l’esperanto che incontra il “Misogistan”.
La donna in viaggio diviene allora scorrimenti di faglia per interpretare il mondo, così come il futuro che verrà. Azema ci mette di fronte il planisfero delle possibilità, il suo lemma neutro, il corpo neutro dell’uomo inteso come soggetto, e come maschile invisibile, a differenza del corpo femminile che, se si muove nello spazio, diviene subito oggetto: di apprezzamento, scherno, violenza. Sono corpi atomizzati, le donne, territori erotizzati, concupiti, dominati e posseduti. Il principio del capitalismo applicato alla geografia dei corpi. Luoghi e divieti organizzati al solo fine di estromettere le cortigiane, il bagno turco, le sultane. Tutti immaginari pruriginosi sulle quali fantasticare. Oggetto del desiderio e turismo sessuale, queste le due mete preferite dal colonialismo misogino.
Se v’è una responsabilità della donna – non di colpa si deve parlare – è l’aver accettato una socialmente accettabile “funzione-specchio” come la definiva Virginia Woolf, la funzione decorativa, d’orpello alle battaglie degli uomini, l’assedio di Troia (quanti facili equivoci sulle parole: paternalismo, mansplaning), l’epica delle donne bottino però è finito, finalmente. Azema ci dice che è la decolonizzazione dei territori il primo passo per la libertà. Il passaggio segreto per l’altrove è il territorio della solitudine. Interessante, a chiusura del libro, la riflessione sulla maternità. L’interruzione del viaggio e l’inseguimento del sogno. Basta vedere le statistiche sui ruoli delle donne al lavoro, quanto guadagnano rispetto ai loro pari livello maschi, idealizzati dalla società con la mistica del padre assente, che va in giro per il mondo a fare affari.
Le Donne in viaggio di Lucie Azema sono cartografe dell’esistenza, rose dei venti, habitat della propria natura. La terra è nera, pincandescente, fragile. Per questo occorre saper andare in frantumi. Perché la ricomposizione è il vento, e il corpo il mezzo per il viaggio che ci rende, tutte|tutti viventi.
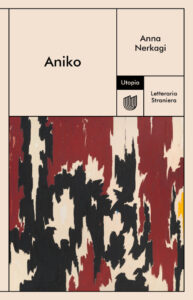
Viviamo nella grande dimensione. Sappiamo allo stesso tempo che è un piccolo virus che ha fermato il mondo degli umani. La narrazione del “too big to fail” appartiene a un mondo fossile al suo ultimo colpo di coda. Non è necessariamente la predizione di Fukuyama sulla fine della storia si avverte però la torsione del mondo, il giro di vite che compongono questo momento storico, in attesa di un futuro che – paradossalmente, data l’epoca tecnologica – pare sempre più lontano.
E’ così che diviene sempre più prezioso lo storytelling del grande pianeta come pretesto delle storie minori, e delle minoranze: è quanto avviene con il romanzo di Anna Nerkagi, Aniko (Utopia Editore, € 18, trad.it. Nadia Cicognini), l’autrice nata nel 1952 nella penisola di Jamal, in Siberia, fin dalle prime pagine ci immerge in una natura selvaggia, e scaltra. I protagonisti di Nerkagi sono lupi e uomini allo stremo, renne piegate dallo sforzo, un mondo di ferocia e ghiaccio, habitat naturale dell’autrice che su quello ha innestato l’habitat immaginato di Aniko.
La scrittura di Nerkagi si sofferma sui punti di vista della Natura, esplora il territorio della tundra attraverso l’uso di parole che provengono dalla cultura nenec, sua lingua natale che l’autrice ha dovuto riscoprire dopo che le autorità russe, quando era bambina, la separarono dalla sua famiglia per costringerla a vivere in collegio. Dopo essersi laureata in geologia, Anna Nerkagi è tornata con la sua famiglia, nelle terre d’origine. Politicamente impegnata nella salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni nenec si batte per la cultura delle minoranze in Russia. In tempi di guerre, grano ed escalation nucleari.
L’autrice siberiana risolve così, a suo giudizio, la vecchia querelle che vede da un lato la necessità di un impegno politico da parte di chi scrive o, viceversa, concentrarsi solo sull’intrattenimento per rendere storie interessanti a chi legge.
Così che quando Aniko, la protagonista del romanzo, è costretta ad abbandonare il suo popolo per andare a vivere in una lontana città russa, ecco che la frattura tra identità dell’autrice e personaggio principale della storia si saldano e compongono. Aniko è il territorio dell’infanzia che Nerkagi vuole ritrovare, e allo stesso tempo il dovere che ognuno di noi ha nel racconto del mondo. E’ così che il nuovo lessico della cittadina sua malgrado, quando torna nel villaggio il burbero Seberuj – suo padre – non sa cosa dire.
Il destino nel frattempo si è abbattuto come una tormenta sul popolo che vive ai margini delle foreste. La Natura immite sommerge e devasta (suona l’eco delle sirene del nostro presente).
Attraverso uno stile asciutto che mette il lettore subito in relazione con le vicende di queste popolazioni indigene minori, Nerkagi compie un piccolo miracolo: per un istante, la durata della lettura del suo libro, ci fa cambiare registro narrativo, ci fa immaginare un altro mondo, fatto di altre parole abitato da personaggi diversi, rispetto a quelli cui siamo abituati. Aniko che parla di mandrie e pastori, dei Čum le abitazioni coniche tipiche degli allevatori di renne. Mentre i lupi si chiamano con nomi che ne raccontano la condizione – Orecchio mozzo, Diavolo zoppo – scopriamo un mondo meno standardizzato, forse, la possibilità di un immaginario altro fatto di altre parole, altri mondi, che sia il primo passo – la narrativa dei popoli minori – per ricostruire uno spazio di racconto, che ci contenga tutti: nomadi, cittadini, renne, alberi, destini.


