
La bellezza di leggere pamphlet sistemici sulla crisi climatica, che scontino in positivo una ovvia parte distruttiva – l’Antropocene, quanto NON stiamo facendo per l’ambiente, le derive nazionaliste e/o social-nazionaliste del nuovo fronte antiglobale – e che però, al contempo, siano in grado di indicare anche un orizzonte di recupero, di futuro, lo srotolamento delle relazioni, l’empatia, una nuova condotta per i co-abitanti del pianeta Terra che verrà.
E’ il caso de La tragedia della lavoratrice-L’alba del Proletarocene (not NERO editions, 15,00 €, trad.it. Claudio Kulesko) scritto a più mani dal Salvage Collective, un super gruppo formato da Jamie Allinson (docente di Politica e Relazioni Internazionali a Edimburgo), China Miéville (scrittore, saggista, critico letterario, attivista), Richard Seymour (London School of Economics, collaboratore del New York Times e del Guardian) e Rosie Warren (editor, caporedattrice di Salvage).
“Il cambiamento climatico è ormai irreversibile – scrivono i Salvage Collective e si, e ci, domandano – Perché non c’è una riunione d’emergenza a settimana in ogni città?”, se è vero che per esempio il sindaco di Dacca ha migliaia di sfollati climatici ogni giorno (i dati ufficiali parlano di 6 milioni di migranti climatici su 170 milioni di abitanti ndr).
Il “manifesto” dei Salvage Collective parte da due utopie. La prima, come si evince dal titolo, è partire (Marx che incontra Nietzsche) dalle donne, nella rielaborazione del futuro che ci aspetta. La seconda utopia è farlo insieme. Come se il capitalismo post-industriale, turbo-finanziario, non ci avesse ridotto, obiettivamente, a tanti “1” che cercano, si affannano, con l’auto-promozione – i social – e l’inganno concesso del marketing a sdoganarsi dalla condizione di “0”, l’esercito degli invisibili di cui tutti facciamo parte.
Da un lato la GDO-Grande Democrazia Organizzata sui prodotti, dall’altra noi lavoratrici, lavoratori sottopagati. Cosa c’entra questo con l’Ambiente?, si potrebbe dire.
C’entra perché non esiste scelta ecologica, o manifesto ambientale, o società virtuosa senza fondi. Tutto costa, sì, anche Internet. Spesso paghiamo la gratuità delle informazioni con i nostri (big) data.
Non si avrà transizione ecologica al mondo che verrà senza passare, necessariamente, da una ri-contrattazione dei rapporti, anche economici. Giustizia sociale, transizione giusta, ecosistemi e culture indigene, rielaborazione dei rapporti, fra uomo-uomo, uomo-animale, uomo-Terra, uomo-donna, un nuovo patto fra viventi che sappia co-costruire il mondo che, ci ricorda il pamphlet La tragedia della lavoratrice-L’alba del Proletarocene è legata alla petrol-modernità entro la quale viviamo, e che invece dovremo superare, se vogliamo davvero avere un futuro su questo pianeta: “Una biosfera della cui distruzione – si legge nel pamphlet – l’umanità è testimone e, al contempo, responsabile”; e che si salverà, a differenza nostra, perché ha a disposizione grandi capacità di adattamento e, soprattutto, un orizzonte temporale di altri 4,5 miliardi di anni.
Abbiamo sbagliato tutti, dicono gli autori: dal revanscismo trumpiano, i neo-liberal e l’attacco a Capitol Hill, le istituzioni democratiche, siamo malati di Stoffwechsel e “culto della morte” (Freud parlava di pulsione) altrimenti non si spiega come: “in virtù degli imperativi a breve termine … il capitale fossile ha assunto un ruolo politicamente privilegiato all’interno dell’emergente economia capitalista globale”, risultato: “un apparato di forze produttive indissolubilmente intrecciato a un’ecatombe trans-specie di massa”.
E già, perché la catastrofe ambientale, l’innalzamento delle temperature come co-conseguenza diretta del nostro mo(n)do di produzione non punta tanto a evitare il disastro planetario quanto un arricchimento crescente, anche a scapito del pianeta stesso sul quale viviamo: “Il capitalismo compromette la sua stessa produttività, proprio attraverso la distruzione industrializzata della biosfera”.
Il tempo perturbante che ci aspetta è caldo serrato a giugno, fiumi in secca, la parola “emergenza” e “stato” coniugati insieme, gli stati vivono in emergenza costante, emergenza d’acqua, e saremo noi a scontarla. Ma non importa tanto abbiamo le bottigliette di plastica. Il Plasticene: abbiamo imbottigliato tutto sotto plastica, peccato che andrà tutta a mare. Siamo preoccupati, ma non quanto dovremmo: le api scompaiono 8 volte più velocemente dei mammiferi in questo momento.
La World Trade Organization: “ha reso illegale la conservazione di semi da una stagione all’altra”, in Brasile: “l’agribusiness ha stretto un’alleanza con Jair Bolsonaro per bollare gli attivisti dei diritti fondiari come terroristi, al solo scopo di estendere le sue zone morte”, ancora: “Siamo colmi di Cattive Speranze”, scrivono questi novelli dickensiani, critic-fordisti hanno il coraggio di scagliarsi contro i mauvais-espérer capitalismo che produce anidride carbonica, invece che l’ossigeno di cui, pure, è fatta la vita.
Infine, il pamphlet soddisferà anche i palati più intransigentemente fini della scienza economica e sociale: aumento delle temperature di 1,5 gradi entro il 2030 e di 3-4 entro il 2100, menzionando la Groenlandia, i dati dell’IPCC – Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, i Summit di Glasgow e Parigi, Biden che commissiona alla CIA un National Intelligence Estimate sulla “sicurezza climatica”, il nesso petromoderno di autolocomozione del capitalismo fondato sul binomio ‘prosperità/libertà’ e le “nuove” rotte attraverso l’Artico (rosso, anche in termini di Russia ed egemonia delle tratte commerciali eventualmente praticabili dopo l’esecrabile definitiva fusione dei ghiacciai).
“Dobbiamo formulare una nuova idea di abbondanza, una che non ignori sfacciatamente i vincoli ecologici”, chiosano i Salvage Collective: chiusure, ur-fascismi, retro-nostalgici, il mondo di ieri si fa sentire mentre il nostro pianeta brucia, siamo però un “noi”, e a noi spetta trovare il balance, una parola che etimologicamente, si legge alla fine del pamphlet: “contiene nella propria radice il concetto di ‘due’ suggerendo una sorta di legame: la coniugazione di due quantità distinte e, tuttavia, correlate e pressoché equivalenti”.
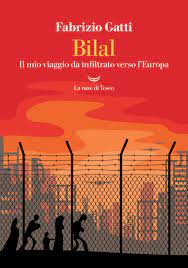
“Le porte chiuse a chiave tremano e battono contro gli infissi”, inizia così Bilal-Il mio viaggio da infiltrato verso l’Europa (La nave di Teseo, 19,00 €) di Fabrizio Gatti è una scoperta e un itinerario: “Dal 2000 a oggi decine di migliaia di persone sono morte nel tentativo di raggiungere l’Europa. E decine di volte i governi si sono rimpallati responsabilità e obblighi di soccorso”.
L’autore, inviato de L’Espresso per anni, ha condotto numerose inchieste per il Corriere e il Giornale diretto da Indro Montanelli. Per questo forse non si fa fatica a leggere la spietata obiettività del fotografo, il reporter che indaga le ragioni, la geopolitica, le stragi sotto la bandiera frivola dei confini: “Eppure nessuna violenza, nessuna linea dura, nessun respingimento ha mai fermato la fuga”. Perché, ci domanda Gatti, i perché sono nel viaggio, nelle ragioni di guerra e di detrimento della condizione; un perché di fuga che troppo spesso fa rima con sommersi e dannati, pellegrinaggi e pericoli affrontati in nome di un sogno, l’illusione di una libertà disarmata, una pace conveniente, il Nord e il Sud del mondo, che non è questione di rose né di venti, oracoli o quadranti sulla bussola del presente.
Il libro-diario di Gatti segue l’itinerario di un mondo profugo, che ha perso tutto, da Dakar a Tripoli (“costerebbe 165 mila franchi. Sono 254 euro, più gli eventuali 800-1000 euro per la barca”), dal Senegal al Sudan (“Migliaia di senegalesi…Poi ci sono i liberiani ai quali la guerra ha preso tutto”, fino al Mali di Ali Farka Touré, il grande musicista maliano intervistato da Martin Scorsese.
Treni lungo il deserto, furti sui vagoni, Sahara, Sahel: “Verso le sette del mattino, il Mistral entra nella stazione di Kita”, le narrazioni di Gatti sono sub-plot di un’unica storia, vite che non sono le nostre ma potrebbero esserlo, potranno diventarlo, se continua la desertificazione del mondo, l’aumento delle temperature che verranno (a Toronto, oggi, fanno 38°C).
Ecco che allora il destino di Daniel e Stephen e Billy, i bambini che si rincorrono, le capre, gli asini che si incontrano nel rivolo di storie di Bilal ci parlano tutte della condizione umana, un libro-immagine, album fotografico di continenti umani in collisione, l’Africa e l’Europa; i trafficanti gongolano in queste vite interrotte, in transito, e deraglio: “Cosa avete fatto di tutta quella coca? I boss l’hanno venduta in Algeria in cambio di armi”, il lavoro d’inchiesta del giornalista si intreccia al racconto del quotidiano: tutto è collegato solo che facciamo finta di non vederlo. Guardiamo il dito e non la Luna. E no. Non ci salverà dal fallimento del presente: “Ai nigeriani va peggio. Forse perché in Nigeria non c’è nessuna guerra civile riconosciuta ufficialmente”. Il pensiero al conflitto di Putin. L’annessione forzosa. I confini che saltano per ragioni economiche. L’Europa un’idea, le oasi di schiavi che vengono dal continente nero, e il predominio bianco imperante: “Il 12 per cento delle persone che partono dalla Libia e dalla Tunisia non arriva in Europa”, meglio penseranno alcuni. E il problema infatti è tutto qui, non ci rendiamo conto dell’umanità attorno a noi, risultato: “gli oltre duecento passeggeri finiti in pasto ai pesci, al largo delle isole Kerkennah”, tiene il conto Gatti, senza retorica, solo numeri: “Hanno raccolto quarantuno naufraghi. Degli altri non si è salvato nessuno”. Sono solo notizie al telegiornale. Lontane.
Giorni di viaggio: è il 2022 sul mondo dopo il secondo anno di pandemia. Va tutto bene. Ultime notizie dal pianeta Terra. E così mentre l’autore, e noi con lui, fischiettiamo River of Life, riverbera l’eco delle parole del testo: dimentica il dolore, goccia dopo goccia, la fine del viaggio non è certo lontana”.
Lungo il Ténéré Mellat, la pianura senza fine, il sole a picco schianta i viandanti. Ci spostiamo alla ricerca del Sole sul pianeta. Ci si sposta per trovare il meglio. Non si parte perché si vuole peggiorare la condizione. La retorica del vengono per rubarci il lavoro e le donne non funziona più. Foss’altro perché il coronavirus ci ha pensato già a destrutturare il concetto stesso di lavoro in Occidente. Sulle donne invece, il ruolo, lo status della donna oggi, meriterebbe più di un’antologia a parte.
Nel frattempo il tempo si misura in scatolette di latte, acqua in bottiglie di plastica, motori d’auto vecchie, pane secco e zucchero. Il mondo di domani non si prospetta niente bene. Il conflitto. Il conflitto e la crisi. I conflitti e il conto dei vivi, della vita: “Abbiamo soltanto due modi di risolvere i conflitti”, scrive infine Fabrizio Gatti, riporta conversazioni di un lungo itinerario, proprio sopra la faglia di confine sulla quale ci troviamo – io, tu, tutti – “Attraverso la parola o attraverso la violenza”. Scegliere l’alternativa starà a noi.


