
Il mondo è troppo grande perché si riesca a salvarlo, ha ragione Jonathan Franzen (qui la mia intervista per La Stampa a pochi mesi dall’uscita italiana).
I livelli di inquinamento che abbiamo prodotto negli ultimi cinquant’anni hanno compromesso l’equilibrio del pianeta. A sentire gli scienziati, praticamente per sempre.
Anche se si dismettesse ora l’immissione di polveri nell’aria, anche se tutto il mondo (in questo momento!) la smettesse di produrre inquinamento, sarebbe troppo tardi.
Il pianeta si è surriscaldato, gli tsunami saranno sempre più frequenti, la desertificazione un processo inarrestabile, soprattutto nel sud del mondo.
Fra cento anni le città potrebbero non esistere più, sommerse dai mari divenuti oceani così profondi da inghiottire tutto.
Le città della costa, la Florida, Venezia, i nuraghe sardi, Stonehenge, la Statua della Libertà sepolta da acqua ghiacciata come nella cover del bellissimo libro di Alan Weisman, Il mondo senza di noi: città sott’acqua e uccelli dentro case disabitate. Pesci giganti che scodino in cerca di cibo. Le creature degli abissi di cui non si conoscevano forma né abitudini di vita. Ora emerse (qui l’intervista all’autore realizzata per la serie Racconti dal Bosco).
Da un’altra parte del pianeta, polvere rossa e silicio dove un tempo c’erano terreni coltivati, Dust Bowl e foreste spazzate via. Il pulviscolo del sole morente che entra da finestroni impolverati e anneriti dai fumi residui di una non meglio precisata nube tossica che ha estinto il genere umano, The road di Cormac McCarthy.
Non serve certo un’ulteriore narrazione catastrofista per immaginare ciò che potrebbe essere, domani. Siamo nell’era della post-Apocalisse.

Ma questo non è un saggio sui disastri che abbiamo compiuto. Quelli li sappiamo. Sono sotto gli occhi di tutti.
È più una riflessione su quanto possiamo fare per evitare che quelle immagini, che si sono impresse così al fondo della nostra retina, divengano, devastantemente, non solo demotivanti ma reali. Il pianeta Terra disabitato.
Non siamo esenti da colpe, certo, lo stesso dobbiamo cambiare modo di raccontare le azioni e le cause. La fabula universale che va avanti dai Neanderthal a oggi: noi e il mondo.
Non possiamo lasciare che il negativo prevalga. Anche se l’evidenza ci racconta che ci comportiamo come i virus – distruggiamo l’habitat nel quale prolifichiamo, fino a quando ne troviamo un altro – lo stesso, probabilmente, posti di fronte alla minaccia dell’estinzione, potremmo riuscire a trovare il senso del pericolo, tipico della specie cui apparteniamo: per farlo, dobbiamo recuperare l’animale sotto l’umano.
Finora ci siamo giustificati dicendo che era tutto troppo grande affinché potessimo cambiarlo, noi, così piccoli.
Cosa avremmo potuto fare infatti per contrastare un sistema che si è costruito per macro-aggregati? Che ha edificato l’estensione del proprio essere sociale su un assunto base quanto darwiniano: Too big to fail.
Oggi, invece, i fallimenti li vediamo, eccome. Lo stesso non possiamo fermarci alla stanchezza causata da un facile e, non meglio identificato, giustificante: il mondo è troppo grande.
Occorre raccontare non solo la parte destruens, critica, del nostro esistere, ma anche la bellezza e la salvaguardia, quanto di noi esista nella natura. Quanto di noi stia – diluito – nei ricordi dei luoghi. Posti che ci hanno visto bambini, e poi adolescenti, infine adulti.
I luoghi, la natura – le vacanze al mare, in montagna, le passeggiate coi nostri genitori per i centro-città a visitare Musei, le sere attorno a un fuoco con gli amici nei boschi – edificazione del nostro essere identità e individui.
Occorre allora ripartire da due cose.
Il bosco
Gli alberi non solo legnatico e polmone, ma spazio-frontiera.
Il bosco è l’incontro di cura reciproca fra uomo e natura.
A livello metaforico, rappresenta il punto di incontro fra lo spazio antropizzato e l’antropizzazione del limite che separa, e allo stesso tempo, funge da primo termine di congiunzione tra la città e il selvatico.
I boschi per essere tali – e non foresta spontanea, locus ignoto che per l’uomo rappresenta il pericolo, lo sconosciuto – devono essere curati.
Il criterio di crescita deve essere un modello di cooperazione e co-sviluppo, pensiero globale perché prende in considerazione tutto. Che lì prevede il taglio degli alberi vecchi per fare spazio ai giovani, e un costante monitoraggio delle zone esterne così da prevedere argini di smottamento prevedibile (la terra frana) e imprevedibile (bufere). Lo stesso occorrerebbe alle nostre società umane.
E se scrivessimo una storia dalla parte degli alberi?
Una storia da un altro punto di vista. Quale voce useremmo. Per dire cosa. The Overstory di Richard Powers.
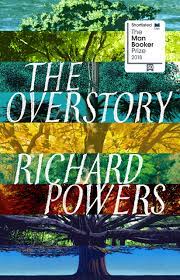
È tempo di dismettere l’antropocentrismo.
Spostarci dalla zona del nostro sapere conosciuto per entrare nella conoscenza di quanto ancora non sappiamo.
Riuscire a portare avanti simultaneamente tutto. È più difficile, occorre studiare. L’abitudine alla complessità è un ribaltamento di prospettiva, quello che ci serve, non certo un aggiornamento del precedente.
Il vicino
Salvare ciò che è più vicino.
L’accanto è, logisticamente, raggiungibile. Lo conosciamo. Per prossimità e abitudine quotidiana.
Quando ne parliamo, lo sappiamo identificare con un linguaggio: una “messa in forma” wittgensteiniana ed efficace.
Le parole accorciano la distanza tra noi e gli oggetti che ci servono per costruire il mondo che abitiamo.
Ci permettono di identificare con un senso condiviso la materia che ci circonda.
I termini che usiamo per descrivere lo spazio ci restituiscono il nostro stesso pensiero.
Pensare in inglese o in italiano un oggetto, non è la stessa cosa. Cambia l’impianto stesso della costruzione delle frasi. Tedesco e spagnolo hanno regole di grammatica differenti, che diventano norme di prammatica diverse. Edificano comportamenti diversi, idee che si sviluppano – concretamente – in modo difforme.
E la forma, come ricorda Mario Vargas Llosa nelle sue Lettere a un aspirante romanziere, è in parte contenuto.
Posporre il verbo alla fine di una frase significa che l’azione viene dopo rispetto l’idea, e ciò da un punto di vista linguistico assume un significato reale.
Quando parliamo un’altra lingua ce ne accorgiamo. Pensiamo in maniera altra: conosciamo meno termini, abbiamo a disposizione un vocabolario-fiume (lo sapevano bene Joseph Conrad e Italo Svevo, con risultati per certi versi opposti).
La lingua è un corso d’acqua sulla quale vengano edificate civiltà.
Stiamo attraversando l’ennesima epoca che si prepara alle migrazioni climatiche. Tsunami e condizioni ambientali sempre più difficili, “guerre diffuse” sul pianeta, nei prossimi anni determineranno spostamenti (smottamenti) di persone, in modo sempre più frequente.
I sovranismi potranno pensare di rallentare questi fiumi fino a un certo punto. Ma gli argini verranno, comunque, rotti.
Sarà fondamentale capire che i nostri vicini, al fondo, siamo noi.
Gli eventi che accadranno nei prossimi anni alle popolazioni che già oggi conoscono la migrazione – l’Asia, ma anche il Sud America, o gli stati dell’ex Est Europa – devono diventare terreno comune. Non tanto, o non solo sugli scranni della politica oggi in agonia ovunque, quanto nelle nostre case.
Ciò che accade al nostro vicino potrebbe accadere a noi.
Lo sa bene il Cristianesimo, così anche l’Islam, l’Ebraismo. L’ospite, lo straniero considerato come sacro: Ulisse alla corte dei Feaci. Ogni vicino è una storia e un evento, monito ed esperienza dalla quale possiamo imparare. Anche a guardarci dentro, e meglio. E ogni esperienza ci avvicina alla salvezza, quando le cateratte del cielo si apriranno. Sapremo quale Arca prendere.

Ora e qui
Anche per gli imprenditori più intransigenti, per i capi di stato negazionisti, per quanti di noi non abbiano misura o abbiano ancora trovato la forza dell’attenzione.
Se pure l’Ambiente non è salvabile solo tramite le risorse rinnovabili, dalla raccolta differenziata, dalle pale eoliche corresponsabili del cambio dei microclimi e della morte di chissà quanti uccelli, in estrema sintesi da quanto saremo in grado di ripulire i mari e l’aria, occorre un salto ideologico che ci permetta di uscire dall’abitudine che, semplicemente, non va più bene per il corpus che siamo diventati.
Il capitalismo non è più sufficiente per rappresentarci.
Ci siamo troppo evoluti. Fa parte del naturale corso degli eventi.
A vent’anni potevamo comportarci in un modo. Oggi, se mangiassimo come allora – salsicce e Nutella – minimo salirebbero i valori di colesterolo.
La Terra è a metà della sua vita, ha oltrepassato la boa: le rimangono altri quattro virgola cinque miliardi di anni prima che il Sole si estingua o esploda e con lui la nostra galassia, e tutti i pianeti che abbiamo imparato a memoria alle scuole elementari.
Se vogliamo far passare bene alle prossime generazioni, i (nostri) figli degli uomini, l’altra mezza vita del pianeta, dobbiamo cambiare prospettiva.
Serve un’altra immagine, dobbiamo inventare un altro ambiente per l’uomo.
Il bosco e il vicino, ma anche la sintassi tra i due termini.
Il bosco vicino
Quello che abbiamo sotto casa. Da proteggere dall’assalto degli immobiliaristi senza scrupoli, dall’erosione urbana che gratta lo spazio verde in favore dell’uso civile.
Dobbiamo tornare a concepire il selvatico. Il terzo paesaggio definito da Gilles Clément, degli interstizi urbani (qui l’intervista al filosofo del paesaggio realizzata per Tuttogreen de La Stampa).

Le piante, i fiori, le strutture naturali che raccontano il divenire dell’urbano prima ancora del divenuto dell’urbe.
Il pregresso che ha lasciato vuoti al progresso.
Il selvatico è il vuoto bianco delle metropoli sul quale si è innervata la città. Il significante semiotico sul quale abbiamo edificato le nostre abitazioni. Recuperare il senso di questo spazio, togliere il criterio dell’abbandono dai giorni: la poca cura per lo spazio pubblico, la disattenzione verso le problematiche altrui che, in fondo, non ci interessano nella misura in cui non ci toccano. Eppure, lo spazio accanto è quel che ci forma.
Un bosco degradato è un limite invalicabile oltre che brutto.
Dobbiamo recuperare la bellezza.
Imparare a curare ciò che amiamo. Partendo da quello che è più vicino.
Occorre vincolare sempre più zone a verde nelle nostre metropoli, negli stati, metterli a reddito aprendo ai viaggiatori la possibilità di camminare, transitare, attraversare.
Un vincolo urbano che preservi queste aree leggere per contrastare le aree pesanti, il resto del corpo urbano, il territorio utilizzato da macchine e funzioni, spazi dedicati allo scambio dei vettori che compongono le attività base della società contemporanea.
Se saremo in grado di creare queste aree sottoposte a vincolo, monumenti aperti a chiunque, riusciremo a decomprimere ciò che accadrà all’altro lato dell’abitato.
Un polmone verde per ogni città. Con una cubatura minima, impostata da un design cogitandi in grado di corrispondere alla cura e alla funzionalità, rivolto alla decompressione dell’uomo urbano: aree di sviluppo psico-motorio per bambini, prati per i nostri laptop, riparo per i vecchi e gli innamorati, ponti di legno e ninfee per i poeti, acqua per tutti.
Chiunque nel mondo ha qualcuno, o qualcosa, accanto.
Così Macchu Picchu verrà protetto da chi è lì, conosce la lingua, quel mondo. Allo stesso modo, se ci impegneremo a condurre campagne d’informazione per fermare l’erosione del territorio a opera delle multinazionali che smantellano le foreste in Brasile, il bosco primordiale in Białowieża (cfr. articoli scritti per il reportage ambientale, settembre 2021 uscito su Il Sole 24 Ore e online per lastampa/viaggi qui).

Se denunceremo chi disbosca la Selva Lacandona, se siamo abitanti del Messico. Allo stesso modo, se siamo nella Terra dei fuochi, non dovrò permettere che si brucino rifiuti tossici sul “mio” territorio perché ne va della mia salute, del mio futuro.
Che ognuno lotti per la propria battaglia.
È un modo per responsabilizzarsi, e non crearsi alibi buoni per non fare niente, e fuggire.
È stato comodo creare associazioni internazionali con le quali prendersela perché non risolvevano i problemi di cui non volevamo occuparci, salvo una volta l’anno fare una donazione.
È un modo per recuperare il contro la globalizzazione che abbiamo lasciato ai sovranisti, ai nuovi-vecchi fascismi, ai populisti che hanno equivocato “Un altro mondo è possibile” in militari armati contro persone in fuga, e muri invalicabili.
Non esiste nessun di qua senza di là.
È in atto una lotta. E noi dobbiamo divenire guerriglia.
Piccoli fronti sui quali impegnare le nostre vite.
Alla fine accadrà che impegnandoci tutti, ognuno nel suo, diventeremo moltitudine.
Domani. Saremo progetto.


