
Fernando Pessoa lavorava come corrispondente commerciale estero per alcuni uffici commerciali.
Scrive tra gli altri Il poeta è un fingitore e il Libro dell’inquietudine.
Cosa significa lavorare e scrivere, dunque. Sono compatibili come mestieri?
Scrivere come alternarsi tra verità e fiducia.
La verità di scavarsi a fondo. Provocando fratture. Scendere nei meandri delle colpe, ferite aperte da non far rimarginare, pena dimenticare l’errore, la palude dei sentimenti, nume tutelare delle ispirazioni, fiato e conserva di ogni aspirante romanziere.
Scrivere o narrare.
Narrare e scrivere.
Antinomie impossibili da sciogliere senza, prima, fare i conti con se stessi. O piuttosto lasciar languire per sempre le soluzioni, irrimediabilmente condannati a riportare in superficie tracce e memorie che altri avrebbero sepolte.
Lo scrittore come un novello Sisifo che torni ogni mattina in vetta a riportare le pietre che lo hanno seppellito.
Sa che non se ne libererà mai.
Non se ne può liberare.
E tutto sommato, forse, non vuole disfarsene. Piuttosto deve imparare a organizzare la discesa. Trovare le parole al fondo. Le parole che ancora non si sanno.
Esaurita la spinta del progresso nucleo tematico del dopo-guerra, il terzo millennio ha deciso di esordire con lo storytelling: si serve di metodi collaudati, in nuove versioni. Da un punto di vista semantico i serial valgono quali feuilleton nouveau romanzi popolari post-contemporanei. “Popolari” non perché il romanzo possa essere letto solo dal popolo ma, piuttosto, poiché donano al lettore-utente la facoltà di attendere il prossimo snodo narrativo, permettendo al contempo il giusto tempo di attesa e lettura.

Umberto Eco ne Il superuomo di massa, e ancor di più nelle Sei passeggiate nei boschi narrativi trattava del tempo quale variabile primaria della scrittura – nelle sue valenze di fabula, discorso e lettura – poiché scrivere, in fin dei conti, non è che leggere.
Il “vero” autore del resto è il lettore, come sosteneva Roland Barthes.
Lo scrittore altro che il semplice “estensore” della lotta contro il dominio delle storie da estirpare all’aria.
La morte dello scrittore allora il passo necessario per chiunque si voglia mettere dall’altro lato del tavolo a battere dita su di una tastiera.
Autore, del resto, etimologicamente deriva da augeo, significa “aumentare”, cosa? Il presente, l’intorno, ciò che percepiamo come realtà.
Quanto dunque un autore sia in grado di far vedere agli altri – i lettori – un livello di (verità più verosimiglianza) maggiore rispetto a quanto essi, i lettori, fossero in grado di fare prima di aver letto la sua opera.
Questo, più che il mercato, dovrebbe essere misura muscolare di chi scrive.
Per questo l’autore è il suo primo lettore.
Leggere è ritmo e tempo.
La scrittura sta nello spazio di una pagina.
La ricerca di un tempo dentro il tempo delle proprie storie.
Il tempo dei personaggi e quello delle ambientazioni, nel genere, l’ambiente di coltura della storia.
Lo spazio bianco a sua volta descrive ciò che sta dentro, e sotto, le parole. Tutto quello che l’autore non scriverà ma il lettore percepirà dietro la forza delle sue parole. È il peso del non detto trasferito in pagina. E lo spazio bianco una balena da arpionare nei mari delle storie, e come arma la sola sintassi. Il terzo livello della parola. Qualsiasi essa sia. Dire “amore” e intendere, al secondo livello, il suo viso. E al terzo livello, la notte e le candele, la grana del cielo mai più blu come quella sera, sotto le scale di legno di una baita in montagna, e le rocce sbriciolate del mondo.
Lo scrittore accetta la solitudine. Sa che nessuno, a parte lui o lei stessa, o la persona a cui dedica, potrà capire.
Il patto col lettore è nella capacità di evocare il fantasmatico. Ciò che si nasconde per mezzo di ogni parola usata.
Il suo portato di dolore, o felicità, di potenza e credo, rutilante attesa e spasmodica avventura.
L’evocativo con cui gioca chi scrive è metafora concreta. Poesia e schiusura. Si condivide per un istante il fardello della verità cui lo scrittore rinuncia in favore della finzione.
La vita come un romanzo. Tutto si ruba, tutto è funzione. Un colore. Due persone si lasciano in un fast food. La prima pagina di un libro.
Lo scrittore è un tentativo. È colui che opera una sintassi tra le possibili, chi ordina il caso con le migliori intenzioni e nessuna capacità. Chi mette in forma il mondo dentro portandolo fuori con la sua voce, e quella dei suoi personaggi.

Ludwig Wittgenstein e Robin Hood.
Viviamo nell’epoca del grande lascito, scrivere è forzatura degli schemi. Il debordare dai confini che la letteratura impone. Punteruolo e il chiavistello per attraversare il limen della mappa narrativa entro cui funziona il mondo immaginato dall’autore, che deve a sua volta divenire mondo immaginario dal fruitore.
Il limes attraversamento e frontiera.
Forzare i limiti della scrittura. Se c’è un autore a cui si deve nella contemporaneità una riflessione sulla necessità di debordare, questi è David Foster Wallace. A volte pesante, a tratti illeggibile, altre dissacrante, in ogni caso “troppo.
Troppo alto, troppo intellettuale, troppo basso, triviale, prolisso, pedante.
Troppo bandana, rough, physique du rôle à la Allen Ginsberg.
Poesia e prosa. Narrativa d’acciaio. Attacco al sistema.
Foster Wallace è morto suicida a Claremont nel duemilaotto.
Se la generazione perduta e la beat generation – Gertrude Stein, James Joyce, Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner – nel Novecento hanno imposto il ripensamento dei canoni borghesi, il presente è il terzo atto, la fine della storia. Siamo nel capitolo che chiude. A noi la responsabilità di intendere cosa farne di questo lungo, o breve, addio.
Tre scrittrici oggi stanno interpretando il cambio di passo della contemporaneità:
– Maylis de Kerangal;
– Ali Smith;
– Zadie Smith.

Maylis de Kerangal, la simultaneità
Scrivere tutto mentre accade.
Mischiando i tempi asincroni di poetica e prosa.
Nella molteplicità delle voci del mondo.
Nel tempo sottostante, sotterraneo, scivoloso della psicologia dei personaggi.
Lo scrittore come uno-e-Molti, cassa di risonanza di moltitudine, la forza della discesa a comprendere gli altri che non sono altro che i gradienti di vita con i quali affrontiamo le onde e i giorni. Senza timore di sporcarsi, morire, fuggire, riflettere, amare.
Non seppellire mai l’ascia di guerra verso se stessi.
Maylis De Kerangal è il salto selvatico.
Il profumo del mirto del Mediterraneo.
La schiuma adolescente dei giorni.
Il tutto operato come flusso di coscienza. Usando la marea indistinta dei pensieri insieme alle azioni e ai dialoghi dei suoi personaggi.
Non usa virgolette, e poca punteggiatura. Tutto è continuo nelle narrazioni di De Kerangal, tutto è Uno, e insieme, contemporaneo senza mai dover essere necessariamente al passo coi tempi. Stilisticamente erede dell’Ulisse di Joyce, quasi, in alcune prove, corrispondenza delle voci evocate, i sussurri che si incanalano nelle nostre vite attraverso le finestre, il vento che sottile si incunea e passa, una lama che trafigge il velo grigio dietro il quale crediamo a volte di poterci nascondere.

Ali Smith, la vita minuscola (qui l’intervista all’autrice realizzata per laStampa)
Se dio è nelle piccole cose.
Se dio esiste.
Se.
La struttura narrata da Ali Smith è costituita da lembi minuscoli che compongono un disegno più grande che solo lei sa vedere all’inizio ma poi, via via che si dipana il fil rouge della storia, anche noi vediamo.
Smith lo fa con salti di prospettiva continui, dal piccolo al grande e viceversa.
La scrittrice di Inverness, quattro volte finalista al Booker Prize, è rivolo d’acqua e fango di città.
Le alte scogliere di Dover hanno lasciato il passo alla Scozia dell’erba impregnata d’umido, buona per le pecore dal vello pesante, e le stagioni segnate dal passare degli uccelli.
La natura e l’uomo. Costante universale che non cede mai all’esaltazione, piuttosto racconta del reciproco scambio.
Interpreta vita e sogno, Smith, li intreccia.
Due piani apparentemente dissimili, solo per necessità separati l’uno dall’altro. In mezzo il Fato sghembo, che prende i giorni e li fa a pezzi.
Pezzi distanti di vite che si intrecciano nel domino infinito delle esistenze.
Smith parla del tempo presente, attacca nazioni, indomita, senza fare sconti a nessuno prima di tutti a se stessa.
L’animo ricorsivo, caleidoscopico, un labirinto che non è più abitato dal Minotauro né privo della sua presenza – come nella versione di Borges e Calvino – ma piuttosto spazio post-apocalittico del locus labirinto, e la sua precisa diretta collocazione come spazio interiore. E poi foglie d’albero a terra, accartocciate e gialle, marroni, verdi. I colori del bosco del prossimo domani.
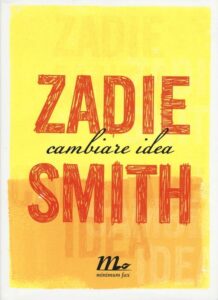
Zadie Smith, l’acume (qui l’intervista all’autrice realizzata per laStampa)
Se c’è un coefficiente di crescita per gli enfant prodige, per i geni che possano crescere sviluppando al massimo le proprie caratteristiche senza per questo cadere dall’Olimpo e dalla quotidianità dell’essere umani – mantenere il livello alto-basso, continuare a scrivere storie da vette irraggiungibili e al contempo non abbandonarsi mai al compiacimento ego-riferito o superiorità – Zadie Smith lo ha assimilato tutto durante la sua crescita. Le sue scelte.
L’ex teen spirit figlia del grunge e degli anni Novanta, autrice divenuta best seller a poco più di vent’anni, ha deciso di non essere iper-prolifica, o più semplicemente non lo è, o non ha ceduto all’eccesso, al sussiego dell’aristocrazia intellettuale: l’autrice qui scrive quel che deve e rispettando i suoi tempi.
Nel frattempo non è salita sul piedistallo, non si tratta come un ente astratto, esente da dubbi, piuttosto sembra incline all’autocritica pur non abbandonando la sua verve.
Zadie Smith è l’estetica del vero, la tua onestà intellettuale mentre guardi il mondo senza pregiudizi. Ricerca che, nella sua scrittura contraddistinta da profonda onestà, appare così radicale da apparire nuda.
Un’autrice classica, per certi versi, che scrive di corpi in collisione e storie di persone, come William Shakespeare o John Keats e Virginia Woolf.
Zadie Smith, scrittrice britannica di madre giamaicana, è essa stessa, ontologicamente, autrice-frontiera, oggi vive e insegna Scrittura creativa a New York.
Nel suo saggio Cambiare idea scrive: “Ciò che gli scrittori del ventunesimo secolo ereditano da Eliot (George ndr) è la libertà rivoluzionaria di portare la forma-romanzo verso i suoi limiti, quali che siano”.
Zadie Smith è forzatura del significato “essere umani” oggi, qui, e per il futuro. È il sociale senza il tempo sottrattivo dei social – “Se non si mantiene il diritto al segreto si entra in uno spazio totalitario”, la frase ispirata di Jacques Deridda – senza infingimenti. Il che per chi scrive fiction è più o meno un miracolo.


