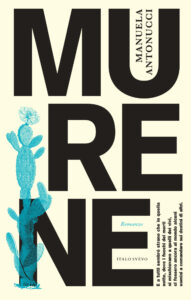
C’è stato un tempo in cui l’Italia era terra arata. I nostri nonni piegati a coltivar verdure, vanga, semina e raccolto, zappe e falci a scassare terreni spesso pietrosi, asciutti, e la poca acqua vera piaga del Sud, la stessa che serve agli uomini per lavarsi o affogare, fondamentale per gli alberi da frutto e gli ulivi da cui si spreme l’olio verde e amaro di quelle terre: “la vita agra”, l’autarchia di una classe intera, i contadini che, spesso, non godevano neanche dei prodotti coltivati.
C’era il latifondo e la proprietà terriera a metà del Novecento, che piegavano la schiena di quelle generazioni molto di più di quanto facesse madre Natura.
Che “la terra è bassa” lo sapevano tutti. In Salento la rivolta dei contadini avvenne in due riprese: una prima subito dopo la seconda guerra mondiale, e una seconda volta tra il ’50-’51. Le ragioni di ribellione erano le condizioni di lavoro aspre, tassi di disoccupazione al 50%, in una terra dove o lavoravi la terra o eri sbirro o malandrino: “Le lotte per la terra, il sangue della rivolta, un Sud dove lo Stato non arriva. E poi c’è Lei, l’Anna, che sparisce nel nulla la notte in cui ha inizio l’occupazione dell’Arneo.”, è qui che si innesta allora la narrazione di Murene (Italo Svevo Editore di Trieste, Euro 16), romanzo d’esordio della salentina Manuela Antonucci da Cupirtinu – paese di circa 20.000 anime in provincia di Lecce – che negli ultimi anni ha lavorato per una casa di produzione spagnola sempre in ambito narrazioni, anche se audiovisive.

E in effetti lo stile di Antonucci è visivo, spiccio, a tratti emblematico. Il romanzo prende l’abbrivio da un dialogo, entriamo nel Salento degli anni Cinquanta, in medias res, proiettati subito dentro questo piccolo viaggio nel “sudditalia” luogo e metafora arcana (qui si possono leggere le prime pagine del libro).
Gli animali, la lenza, la fame, Tonino e la pesca, il curciulu, il bambino, nel libro d’esordio della salentina la lingua è terra ulteriore, luogo-confine, immaginario su cui innestare la Storia con la S maiuscola, la predica del prete alla domenica delle salme, il western degli estinti, quando le rivolte dei contadini si scontreranno con i potenti di turno e il pessimo governo Scelba, le leggi a garanzia del dominante, e i poveracci a fare sempre quel che sanno fare. Gli straccivendoli dell’esistenza.
Le vicende narrate in Murene sono epos secondario, nascosto, polvere dimenticata sparsa sul terreno, morti ammazzati e amputati dai giorni. Un’esistenza contadina che abbiamo fatto finta di dimenticare, oggi come oggi, come si dice, di questa epoca pandemica sempre più tecnologica. E pensare che fino a ieri i nostri nonni, appunto, mica cent’anni fa, cent’anni fa c’era la grande influenza spagnola, la prima guerra mondiale.
Nel romanzo di Antonucci invece c’è la metà del Novecento, la provincia e le lotte sindacali, c’erano ancora, le persone si sentivano quarto stato, quinto, in ogni caso “insieme”. Il capitalismo latifondista non li aveva piegati, a farlo ci avrebbe pensato più tardi la versione industriale prima e poi quella tecnologica.
Sulla via del furore dei contadini, Antonucci innesca una narrazione per immagini, evocativa, i fantasmi però qui non sono solo i morti (che pure ci saranno, davvero) ma i dimenticati, è una storia di falò e bicchieri di vino rosso, quella in cui incontriamo quasi per caso Anna.
Anna che si guarderà la pancia schiuma di mare. Anna che legge libri “A che ti serve?”, Anna che si trova a vedere pentole e pure coperchi, Anna che ha le contrazioni, mulinelli sott’acqua, spinta del parto e nero, Anna che in sole tre pagine entra dentro come un ferro arroventato. O forse siamo solo noi che siamo più sensibili in questi anni nostalgici, noi che vorremmo essere in campagna forse per la prima volta, a toccare con mano le spighe di grano nei campi al tramonto.
Ci sarà la Riforma Agraria, ma prima Tonino ritroverà Anna, e Pompilio scenderà dal treno (che meraviglia dev’esser stato vedere i primi treni a vapore in quegli anni, quando il futuro sarebbe stato radioso e gli uomini non avevano certo pensato che il cavallo di ferro avrebbe espropriato terre, cacciato contadini, arricchito i soliti).
Sono questi gli anni della politica delle grandi masse, dei movimenti di lotta, degli uomini che portavano i calzoni, di “uomini e topi” ma qui i topi nel romanzo di Antonucci stanno tra le pale dei fichi d’India nella strada per Maglie, nascosti, mentre i contadini restano esposti ai venti della tragedia che si abbatte, il vento dell’inclemente capitale che li schiaccerà, qui, e poi per sempre.
In Murene i protagonisti sono loro dunque, i braccianti agricoli, le loro donne, storie di famiglia e terra, fazzoletti in testa e onestà, camicie sporcate e panciotti, cappelli e il Far West nostrano, quello senza eroi, dove l’unica macchia è quella mediterranea e le murene invece? Per sciogliere lo snodo narrativo del titolo bisognerà attendere Celestino, “c’è una cosa che distingue gli uomini dai pesci, e quella è l’intenzione” scrive l’autrice a due passi dalla fine.

“Terra! TERRA!” il racconto si compone di specchi e riflessi di un tempo (quello dell’Italia contadina di cui così poco si è narrato nella nostra letteratura contemporanea, altro merito del bell’esordio di Antonucci), e poi via via arrivano giù tutte le altre pietruzze fastidiose dentro le scarpe da srotolare nel destino dei ‘chiunque’ di questo scorcio appolverato: Pietra che accarezzava le bestie, Ernesto e la mammana, don Fulgenzio e il clan del maresciallo Cacciatore, Vito e le serate estive e i cicaluni in testa, Minicu Precamorti noto ricettatore d’oro: è pieno di protagonisti e secondarie comparse questo esordio, un bell’esempio di scrittura contemporanea sul solco neo-realista, mai stinto, lo stile di Antonucci non è mai ridondante, mai auto-riferito ma sempre utile alla narrazione, progressivo, ogni scena serve alla storia piccola e minore di cui ci vuole raccontare, un mantice sgrammaticato, dignitoso come i personaggi di cui tratta – i nostri nonni, della “povera patria” nel senso etimologico, di “terra dei padri” -, secco e asciutto come la terra d’ulivi secolari del Salento (prima dell’attacco della Xylella ndr).
La storia nelle narrazioni finisce sempre alla stessa maniera. Coi roghi delle biciclette e delle coperte e i fucili e le forze dell’ordine che sederanno – futuro semplice dell’infinito “sedare” – la rivolta e l’Italia così potrà continuare nel suo percorso di abbandono delle terre. Tema mai attuale come adesso, con la crisi post-pandemia, in cui molti giovani riscoprono la terra “che (sempre) bassa è” però.
Un’ultima osservazione sulla pregevole fattura dei testi della Italo Svevo, piccola casa editrice di Trieste, terra di confine e vento, e del progetto grafico di Maurizio Ceccato, che rende i libri (ad acchiappar storie, e sogni direbbe Shakespeare) per farne esperienza e materia, oltre che darci l’illusione dell’home made della lettura: per leggere il romanzo, infatti, occorrerà che prima vi procuriate un tagliacarte.
canzone da ascoltare durante la lettura: Albert af Ekenstam, Made of Gold


