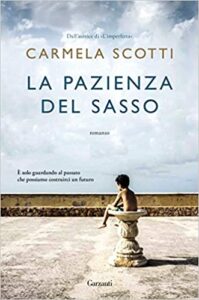
Cosa possiamo chiedere alla vita, e perché? A chi, soprattutto.
Le mentite spoglie.
Inizia con le ceneri di una sorella l’ultimo romanzo di Carmela Scotti, La pazienza del sasso (Garzanti,€16,90): “un mucchietto di fosfati di calcio, zolfo e carbonio”. L’effimera invisibilità d’ogni speranza. Pochi istanti di vita, in una manciata di composti.
C’è una prima persona che parla, la forza e la supplica. Scotti innerva l’estinzione fin da subito a mettere in chiaro le cose, per dare subito l’antifona a chi pensasse che questo libro è una frontiera, se tutto disappare. In tempi di pandemia. Affronta l’inaffrontabile a occhi aperti. Parla di morte.
Pianeta Terra, primavera 2021, quasi 3 milioni di morti di coronavirus. E pure i lillà sbocciano, T. S. Eliot ci parla, i prati in fiore. La fragilità delle parole-stella di Carmela Scotti sono fratture su uno specchio di gemma, onice che avvampa “un medaglione d’argento con le rose stampate che mi aveva regalato pochi anni prima che il terremoto del Belice cancellasse per sempre le nostre vite”.
I personaggi dell’autrice de L’imperfetta (finalista al premio Calvino, 2016) respirano coraggio. Sanno che ogni faglia che si apre nel corpo resta. Così la sorella morta, Dervia, riaffiora e le cicatrici non si rimarginano. Le donne di Scotti decidono di mostrare il corpo, non lo sottraggono alla vista, sono amputate, incomplete, indomite. Se c’è un merito di certa prosa italiana contemporanea è l’umiltà delle parole, l’insicurezza nella relazione col mondo “i miei ricordi: eventi banali, aneddoti rovinati come unghie mangiucchiate”, la pelle esposta, la propria insipienza, nonostante la cultura dell’immagine ci voglia pur sempre appagati e stanchi, immarcescibili e potenti, vanitosi, sicuri.
Ecco, il Belice è un’esistenza che crolla, una metafora al vento e la polvere che cancella ogni cosa. I paesi piccoli e minori di un’Italia abbandonata, non dallo Stato, chi se ne frega, dalla fiducia piuttosto, il senso del futuro e lo slancio dopo l’abbandono.
Argia, Dervia Delveri (la verità, quale?), Selvaggia (Foresta). Persino i nomi sono storpi nelle storie, siamo Nessuno, come Odisseo (il cui significato, in greco, è esattamente irato) come l’illusione della vittoria, il bicchiere mezzo pieno.
Nel pulviscolo dei giorni, Dervia che muore: “il bersaglio che per tutta la mia esistenza ha incassato le mie raffiche fino a quando non c’è stata più carne da colpire”.
Ci si prenda la responsabilità. Che la colpa è cattolico-cristiana. La colpa è espiabile.
Le eroidi di Scotti non cantano l’ira, l’abbandono, raccontano l’assunzione.
Che fine fanno i poveri, non frega niente a nessuno, basta che stiano lontani dallo sguardo, lontani dal cuore. E invece Scotti è lì, una scrittrice per empatia, un rigo di polvere sul volto, bambini all’aria, cani magri che frugano tra i ruderi del Sud.

Lo scandalo, le paghette statali a chi ha perso tutto, non si risolve mai niente, tutto rimane sullo sfondo, tranne le vite degli uomini. Noi. Quando ricominceremo a piangere, come se ci chiedesse quest’autrice?
In un mondo pieno di persone che sanno tutto e sanno niente, in un pianeta Terra ripiegato su se stesso, noi al centro del mondo, La pazienza del sasso rotola verso di noi con un viaggio e una destinazione. Parole d’elezione neppure duinesi, Scotti parla semplice e ai semplici di García Lorca si rivolge, a questa umanità fragile che non finge: “I pensieri sono lo strumento più adatto a superare il legno dell’urna e arrivare da lei, dirle tutte le mie mancanze, tutto quello che avrei voluto essere e che non sono stata”, mai malcelata auto-indulgenza nelle parole di Scotti, la sintassi dell’ammissione, un’autrice “poemica” se ci si passi il termine, silenziosamente dickinsoniana, cosa importano i baci se si sono estinti?, “sperando davvero si tratti di una pietra, prima che la velocità lo trasformi in una cosa del passato, lasciata alle spalle per sempre, dimenticata”. La cura e l’abbandono, l’isola dei sentimenti.
Scotti l’ho incontrata al Premio Fondazione Megamark, insieme a Cristian Mannu, un altro premio Calvino, e Valerio Callieri. Neri Marcorè l’aveva incoronata vincitrice, reminiscenze di una sera di mezz’estate.
Se v’è bisogno di storie e di nessuna alterigia, parole che sommesse varchino le cuciture del cuore, nelle vicende di cui tratta Scotti non c’è finzione, lo stridio del proprio corpo quale frizione al mondo, un attrito appena, stelle sul corpo e linguaggio.
Forse anche perché i luoghi che cogliamo, gli angoli gli spigoli del mondo, in fondo non esistono, aveva ragione Anaïs Nin (alla cui figura è dedicato il pregevole graphic novel di Léonie Bischoff appena uscito per L’Ippocampo).
Siamo atlanti immaginari in cerca di animali fantastici, a volte balene bianche, mostri marini, “L’ho odiata, Dervia, non ho fatto che questo, e adesso ogni cosa di lei dorme, comprensione, bugie, verità e bellezza, e io sono rimasta sola a ridisegnare i confini di ciò che manca”.
Troppo spesso i marchi a fuoco determinano stupidamente il corso e gli eventi. Una certa autrice ha successo. Un’altra, siccome parla di donne, allora scrive “romanzetti rosa”, per donne. Quanta misantropia corrode il mondo.
Lo stile d’un autore, forse, è solo mancanza, Carmela Scotti scioglie misura singola in ogni lettera, come la “e” scomparsa di Georges Perec; abrade e rumina corteccia, scioglie rapporti e non dà ragione, non se la piglia, non cerca risposta. Piuttosto abbandona. Dissipa. Il tempo è compreso nel prezzo.

Sì è vero, ne La pazienza del sasso la trama è familiare, pure non c’è che lessico, e radice. I tasti di un pianoforte che sfiorino i ricordi: “il Chiaro di luna di Debussy per i momenti di malinconia, una ballata di Chopin per mandare via la tensione, la Sonata n. 11 di Mozart per celebrare le giornate felici”.
On Reflection di Max Richter per chi scrive.
La Sicilia di Trapani e Palermo, Scilla e Cariddi, il mare, la nonna Ada, l’idea che tutto dovesse – dovesse? – durare per sempre: “Sono morta il giorno in cui è nata mia sorella”, quanti figli abbandonano il gioco della vita. Quanti di noi si perdono, quanti lasciano il giro di vite prima del tempo. Per caso e incomprensione. Chiedere e non ottenere. Trilobiti al posto dei sogni. La solitudine in mezzo: “Il dolore a colori non si può raccontare”, mette a nudo a pastelli e cieli di settembre, Scotti, memorie di fuoco e tempeste, giorni cupi: la pazienza è un sasso al centro del petto, un grumo scuro dentro lo sterno, la ferocia che ci fa diavolo senza acqua santa: “mia sorella metteva la sua vita nelle mie mani e io, invece di farne un nido per accoglierla, le nascondevo dietro la schiena”, i bambini, gli alberi a tiglio e furti, il peggiore di tutti: “A cosa si è disposti per farsi amare?”, a cosa si è disposti, aggiungerebbe l’autrice siciliana, diplomata in pittura e fotografia all’Accademia di Belle Arti di Palermo.
A questo punto, Nick Hornby farebbe una lista e ci chiederebbe, ok adesso fatelo anche voi. Mettete giù le 5 cose peggiori che avete fatto al vostro amico, partner, sorella, fratello? Non indorate la pillola, scrivetele senza aggiungere niente, togliere le cose di cui vi vergognate, elencatele e basta. Ok, fatto? Bene. Chi è lo stronzo adesso?
Al questionario di Proust, oggi, si dovrebbe sostituire la top5 dello scrittore britannico di Alta Fedeltà.
I personaggi di Scotti non hanno bisogno di definirsi, lavorano, mutano, muoiono. Nessuna etichetta. Scompaiono, e allora a noi non rimane che aspettare l’evaporazione del futuro, l’abbandono che non capita in città, a Milano, Montreal, New York City, ma a Musolino Nuovo “un agglomerato di costruzioni destinate a chi aveva perso tutto nella scossa e che assomigliavano a scatoloni pronti per essere spediti”. Sembra L’Aquila. Oggi, ieri, Norcia, Giotto, Assisi, tutto distrutto. Non va tutto bene, no è falso, sono falsi i vostri sorrisi, sono false le parole tranne quelle dichiarate sul greppo e la falesia. La tragedia non è essere nati, la tragedia è fingere: “un’allegria recitata male”.

Ratto di Proserpina, Gian Lorenzo Bernini, 1621-1622
Galleria Borghese, Roma
Il mondo dei vivi ne La pazienza del sasso si mischia, l’autrice sicula conosce l’Averno, la Grecia classica che faceva volgere volti d’amanti prima del tempo, e allora saremmo stati tutti confinati per sempre all’Ade, Persefone rapita, come Dervia in preda alle crisi mistiche in contatto coi morti, Cassandra muore: “Diceva di non sapere come ci riuscisse, che il suo era un “dono”. Se non fosse stata mia sorella, non le avrei mai creduto, ma poi vedevo il mio corpo tremare sotto i colpi di un terremoto invisibile, gli occhi puntare a un vuoto che qualcosa doveva contenere, un vento, una voce lontana, e capivo che non mentiva”.
Il futuro negato ai sopravvissuti al terremoto, non del Belice ma del cuore. E non il battito romantico, piuttosto il ritmo che ci tiene semplicemente in vita. Senza troppi ricami. Scotti arriva dritta senza strizzare occhi, grandi, né facendo boccucce. Pare integerrima, da fuori, ma chi siamo noi per valutare uno stile, una forma, una parola?
Cos’è tutta questa smania di successo. Quando abbiamo scordato il pacato mettersi da parte e, al posto di una vita appartata, abbiamo scelto di spiare dentro gli appartamenti altrui?
E’ la pandemia, bellezza, diranno i complottisti del Grande Fratello digitale.
Ecco, tutto questo non c’è per fortuna, nei libri di Scotti. Ci sono donne, uomini (pochi e sullo sfondo, è il tempo delle ragazze questo, magari, il futuro: loro, dei ragazzi della generazione Greta e dei negri uccisi dalla polizia di mezzo mondo), l’inconsistenza del concetto di “amore”.
Perdersi, cadere, affondare. La fuga per ricominciare, ma perché? Dove le troviamo le forze, oggi poi, rinchiusi in casa da quanto? Il presente un labirinto inestricabile, il minotauro non è il mostro di ciò che, né la nostra immagine, il minotauro è il futuro, sembra suggerirci Scotti: i concorsi che vinceremo e le battaglie perse, le posture della fuga e i costoni di roccia franati. Gli scogli della costa di Girgenti, quanti di noi vivono per i figli, il progetto di una vita. Ma noi, dove siamo finiti? Dove, le passioni del noi individui, l’io bambino che costruiva mondi, Nicola e Lucio “Se lo racconti, diventa vero” scrive Scotti “è così…che nutro la mia espiazione”, è così che si arriva alla tragedia nel suo significato classico: “un amore che, sono sicura, è esistito prima che tutto crollasse, prima che noi figlie fossimo gettate nelle fauci di una madre diventata artigli. “Colei che dilania”, scesa in picchiata sulla nostra infanzia come l’aquila sul cucciolo di agnello. Quello che restava di noi, dopo il banchetto, non era che carne svuotata, un guscio che il tempo ha reso secco e polveroso”.

Nishiyama Hōen, Various Birds, a handscroll painting, 1820/1867
British Museum, London, Regno Unito
Gli esseri umani non sanno volare, neppure Icaro, neppure le valigie con cui crediamo di sbarcare la luna e il mondo. Le crepe, i superstiti, le frasi di Scotti girano tronche, omografe, l’autrice slitta tutto il piano semantico sui colori, le sabbie mobili, nessuna bella frase a effetto, San Francesco dei poverelli che canta il giardino dei semplici, Laudato sì, mi’ Signore, per sor’acqua, che anche chi è ateo dovrebbe leggere i testi sacri, non per il credo ma per il luogo sacro degli dèi: “Avevo deciso…di recitare fino in fondo la parte del Dio cattivo che divide le acque, che decide della vita e della morte, dell’odio e dell’amore”.
E Scotti fa anche questo, allora, ci fa parlare con gli spiriti, un triangolo illuminato nel cielo, Dio è femmina, io, tu, la ragazza mulatta venduta per strada, raccolte di nubi a distesa sui prati d’erba, l’orizzonte una questione di luci e ombre, il caravaggesco fantasma degli affetti, la scena madre di uno schianto. L’alfabeto di Dio al mutare delle stagioni.
Beddu, beddu, dduci e ‘nzuccaratu. La lingua mette in forma il mondo. E noi mettiamo al mondo bambini. Siamo ere geologiche e felicità diverse. La pazienza del sasso è una domanda. Se crediamo ancora alle fiabe. Cosa siamo ancora in grado di “sentire” nonostante tutto. Clic. Carmela Scotti scioglie vite come mercurio, passa rada sopra le loro teste, non interviene, resta scaltra sul bordo dell’attesa. La pioggia, il frammento, la bellezza da custodire: Quando ho preso quella casa, ho liberato tutti gli uccelli”. Guardare fuori. Al mondo, all’altro. E che, per vivere, bisogna toccarli gli oggetti, il freddo, “i resti di due fuochi spenti”, effathà, la verità come la vita, leggera e senza paura.


